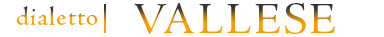IL DIALETTO ISTRIOTO DI VALLE D'ISTRIA
Valle è, dal punto di vista linguistico - accanto a Rovigno, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano, - uno dei pochi luoghi in Istria dove ancora oggi è possibile sentire dalla viva voce dei parlanti nativi il più antico dioma della penisola: L'istrioto. O, per essere più precisi, ciò di quell'arcaico parlare è ancora rimasto in seguito alle inevitabili variazioni - fonetiche e lessicali innanzitutto -, determinate dal succedersi storico e dai cambiamenti culturali, sociali, politici che hanno caraterizzato queste terre.
Nel 1681 Prospero Petronio nelle sue Memorie descrivendo Valle riportava tra l'altro: "quasi tutti parlano l'italiana con poca differenza dalla favella che s'usa a Rovigno (...). Oggi invece, sono pochi coloro che ancora parlano quella "favella", soppiantata sempre più dall'istroveneto e in particolare dalle due lingue standard: l'italiano e, in seguito all'esodo della maggioranza della popolazione autoctona italiana, dal croato.
Privo di una codificazione scritta, salvo per una poesia in vernacolo, scritta nel 1932 dal F. Giuliano Palazzolo, ed una trascrizione della Parabola del figliuol prodigo, l'istrioto vallese è stato da secoli essenzialmente strumento di comunicazione orale, usato in un contesto che da sempre è stato quello della campagna e dei lavori ad essa attinent, nonchè quello dell'allevamento del bestiame e dei lavori domestici. A questo ha fatto riferimento, Giovanni Zaneto Obrovaz, scalpellino e scrittore autodidatta, il quae nei suoi dieci quaderni in dialetto vallese ha trascritto tutto ciò che considerava degno di nota; proverbi, avvenimenti del passato, usanze popolari, descrizione dei lavori in campagna, degli attrezzi agricoli, superstizioni. filastrocche, canzoni, nonchè abbozzi di grammatica e di un rudimentale vocabolario vallese-italiano.
Oggi, però, essendo quasi completamente spariti gli antici mestieri e con essi quel determinato modo di vita, cessano inevitabilmente di sussistere pure moltissime espressioni, termini e voci appartenenti ai rispettivi campi semantici. Il parlante in dialetto odierno immette nel suo discorso locuzioni e vocabuli presi da altri sistemi linguistici, in primo luogo le due lingue standard, e, inoltre, può alternare ai già menzionati idiomi un quinto codice espressivo, il dialetto ciacavo croato. Tutti questi codici influiscono sul vernacolo modificandone la struttura sintattica, il lessico, come pure la pronuncia, il tono, ecc.. cossiché, ad esempio, la nasale [n] in numerose parole in posizione intervocalica (luna, carsedana, cadena, ecc) non si realizza più (eccetto forse nei pochi anziani ancora viventi) come una nasale velare bensì come una semplice nasale dentale; così avviene con le parole ossitone (barcon, can, pan, ecc.) pronunciate con la consonante nasalle dentale. Ancora in Obrovaz troviamo la trascrizione dell'avverbio "più", e quindi pure la sua articolazione, come piun: Scrive l'autore nel decimo quaderno: "(...) Quando poi si incontra la parola "campana", "mezzana", si farà un segno sopra la "n": "ñ", che significa la "n" nasale. Questa "n" serve su molte parole che incontrerete. Dovete più volte leggere per entrare nell'espressione. (...)
Oggi all'originale pronuncia si è sovrapposta quella dell'italiano standard. Nel sesto quaderno l'autore ci offre pure un semplice abbozzo di codificazione grammaticale, riposrtando alcuni tempi dell'indicativo del verbo "essere" e "avere" in italiano e in dialetto. Fornisce, inoltre, degli esempi di proposizioni con il verbo - che sottolinea - all'indicativo presente:
Il muratore costruisce le case. L murador fa le case.
Il falegname pialla. L marangon spiana.
Il mare è profondo. L mar ze fondo.
Il passero vola nell'aria. L seregoto sgola n aria.
Il quaderno è vecchio. La teca ze vecia.
Trattando alcuni aspetti della tradizione popolare di Valle ho dato ampio spazio al dialetto istrioto, ovvero all'originaria espressione in cui queste conoscenze sono state tramandate di generazione in generazione.
Al fine di facilitare la lettura e la comprensione del dialetto vallese ho adottato, nella trascrizione e per la pronuncia, le regole morfosintattiche dell'italiano, con poche eccezioni. Nel gruppo sc seguito da e, i la sibilante va pronunciata staccata rispetto alla palatale:s′cinca, fis′cià, s′ciopo, ecc. Nel vallese non esiste la geminazione. L'alfabeto è costituito da 21 lettere che si pronunciano come le corrispondenti italiane: vi mancano i suoni che nell'italiano sono resi dalla lettera z, cioè le affricate /ts/ e /dz/. Con questa, invece, ho reso la pronuncia della fricativa prepalatale sonora /ʒ/ : zero (it. zero), zalo (it. giallo), ezame (it.esame), ze (it. è), zà (it. già), ecc. Il suono è molto simile, ma un po' più tenue, alla pronuncia francese joie /ʒwa/ o dall'inglese vision /'viʒan/. Il corrispondente suono sordo viene invece reso dalla lettera s: roso (it. rosso), specio (it. specchio), speransa (it.speranza) e si pronuncia come in italiano il nesso sc della parola sciame /∫ame/. L'Obrovaz, invece, nei suoi scritti trascrive indiffertemente le due distinte realizzazioni sonore, rappresentando la fricativa prepalatale sonora /ʒ/ a volte con la grafia "z", altre con "s". Così pure negli scritti in vernacolo del Palazzolo, il quale, inoltre, rende sempre la terza persona singola all'indicativo presente del verbo "essere" nella versione veneta, xe. Non sussite, infatti, tra gli scriventi il dialetto istrioto una norma arbitraria ed unanimamente assunta come rappresentativa delle querelle in questione. Compare, invece, in alcuni autori, per la realizzazione grafica del controverso fonema, il segno rappresentante il fonema prepalatale /∫/, il che non fa che confermare, ulteriormente, l'ambiguità sussistente nell'ambito della trascrizione del dialetto.
Con la semivocale j ho indicato soltanto le forme verbali dell'ausiliare vé (avere) dell'indicativo presente: mi je, ti ti je, lui jo, lori jo. Nell'Obrovaz invece, le stesse vengono realizzate nelle forme iè, iò.
Un certo numero di parole inizia con le nasali m o n seguite da consonante, le quali, in seguito all'aferasi della vocale iniziale sono rimaste all'inizio di parola come nei casi: ndrio (it. indietro), mparà (it. imparare), ntapà (it. tappare), ntivà (it. azzeccare), mbriagon (it. ubriacone), ecc. Riscontriamo lo stesso caso di aferesi nell'articolo determinatico maschile singolare 'l (it. il) o reso anche come el, nonché nell'articolo indeterminativo maschile e femminile singolare 'n (it. un, uno) reso ancora come un, 'na (it.una), e nella proposizione semplice 'n (it.in). Anche in questo caso riscontriamo diversità di trascrizione, con o senza apostrofo al posto della vocale elisa.
In una nota riguardante la Parabola del figliuol prodigo in dialetto vallese, il canonico Pietro Stancovich scrive: "È rimarcabile l'ortografia del dialetto di Valle particolarmente, nel quale la vocale della voce seguente viene elisa al modo dei quattrocentisti con Dante e Petrarca. Questa elisione in quel popolo si conosce apertamente nella pronuncia, come nelle voci "che 'l jo magnà N.°14 - vignà 'n sì N. °17 - peccà ìn contra Iddio N. °18 - Dà 'n vedel grasso N. °25", pronunciano la "l" unita alla "jò", dicendo "ljò", così " 'n sì - 'nsì, 'n contra - 'ncontra" (...) Conviene credere che ai tempi di Dante si pronunciasse in questa foma per tutta l'Italia, perché vediamo scritto quel Poema con simili elisioni. Questa pronuncia da noi non si conosce, ma in quel popolo italiano tuttora sussiste. Di più ancora il popolo di Valle ha una particolarità di lingua del verbo andare, che corrisponde pure ai tempi di Dante"
E l'Obrovaz, nell'abbozzo di grammatica di cui sopra, dà le seguenti regole morfologiche e fonetiche di alcune pecularità del vernacolo vallese:
Quando vogliamo scrivere il dialetto vallese, in nessuna parola non si metterà doppia consonante. Per esempio "Vallesi" si farà "Valesi", "freddo" : "fredo", e così avanti.
Quando poi s'incontrerà la parola che chiama due "esse", noi faremo un solo "s", "fosso" : "fošo", "fosse" : "foše" con una forchetta sopra la "s". Così anche per la lettera "n" si farà un segno sopra la "n": "ñ" come "campana" in vallese "campaña", "tramontana" : "tramontaña", "mezzana" : "mezzaña" e così via.
Il più che conta è di dare l'esatta espressione nel leggere per sentire la cantilena vallese. Per ottenere questo dobbiamo leggere una pagina magari tre volte per riuscirci bene.
Va però tenuto presente che neppure l'autore stesso rispetterà sempre questi precetti, anzi, come ci rileva Silvana Turcinovich, "parole istriane venete e dell'italiano letterario subentrano al corrispondente vernacolo, senza che il nostro lo noti, Insicura è anche la trascrizione fonetica: numerosi sono gli esempi di consonanti geminate, non è distinta l'opzione tra la sibilante sonora z e quella sorda s. Poco rispettata è anche la punteggiatura, sorvolati talvolta gli accenti (...)". Certo è però che Giovanni Obrovaz, seppur con tutte le imperfezioni grammaticali che possiamo riscontrare nei suoi scritti, ha il grande merito di averci lasciato la più ricca ed esauriente testimonianza del dialetto vallese, attraverso la quale possiamo conoscere quello che era l'autentico aspetto dei modi di vita degli abitanti del paese, delle sue tradizioni e consuetudini, costumi, ecc.
-tratto da "Valle d'Istria: note storico-antropologiche" di Sandro Cergna.